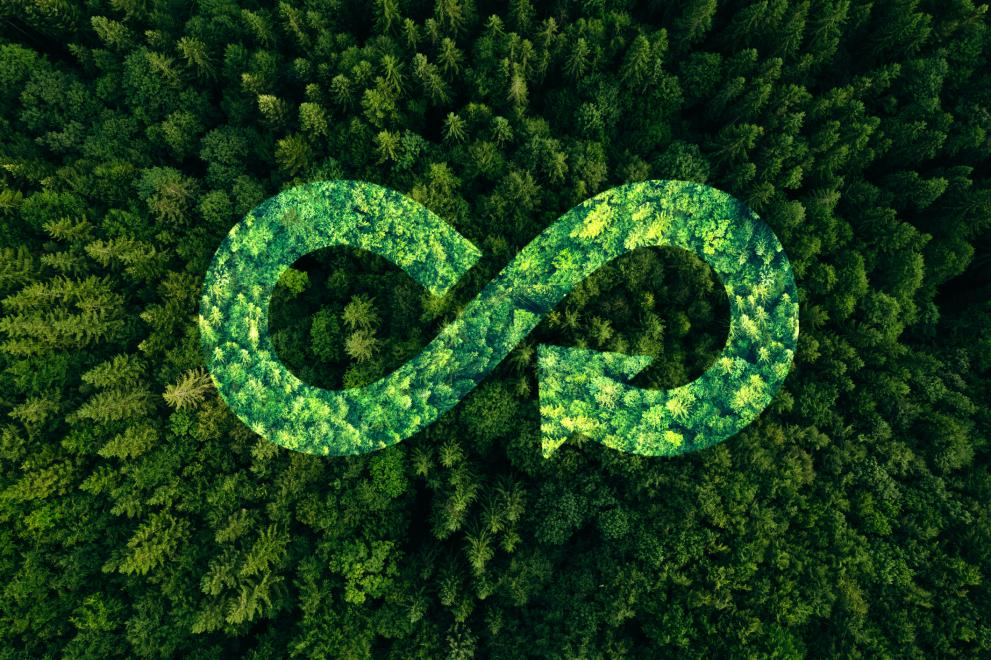Dopo aver distrutto sistematicamente ogni infrastruttura civile a Gaza, trasformando la Striscia in uno dei luoghi più inquinati del mondo, senza acqua potabile e senza rete fognaria, Israele se la prende con la combustione illegale dei rifiuti e lo scarico di liquami in Cisgiordania. Il governo ha definito questo fenomeno una “minaccia alla sicurezza nazionale”.
Nel mirino sono finite alcune fabbriche palestinesi a sud di Hebron, accusate dal Cogat – l’ente israeliano che gestisce gli affari civili nei Territori – di aver inquinato il fiume Hebron e l’aria delle aree circostanti, fino a colpire città israeliane come Beersheba. Sono scattate sanzioni, revoche di permessi e perfino la chiusura dei sistemi fognari degli stabilimenti. Parallelamente, il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich hanno annunciato un piano di emergenza: sequestri di camion dei rifiuti palestinesi, rimozioni forzate, nuovi siti di smaltimento in Cisgiordania, con i costi imputati all’Autorità nazionale palestinese.
Perché l’inquinamento arriva fino alle città israeliane
A Shoham, nel centro di Israele, il Ministero della Salute ha invitato i residenti a restare in casa durante la notte, chiudendo finestre e spegnendo i condizionatori. Una misura rara, adottata dopo che un rilevatore mobile ha registrato livelli di benzene e di Pm2.5 – polveri sottilissime che penetrano nei polmoni – ben oltre i limiti di legge. Il benzene è una sostanza cancerogena; il Pm2.5 è il particolto atmosferico, che può aggravare o causare gravi problemi respiratori.
Secondo le autorità israeliane, la causa principale sono i roghi illegali di rifiuti in Cisgiordania, in particolare plastica e dispositivi elettronici. Bruciare questi materiali rilascia nell’aria metalli pesanti e sostanze tossiche che non si fermano alla Linea Verde, il confine tra Israele e i Territori occupati. Il fumo viaggia, spinto dal vento, e colpisce comunità israeliane e palestinesi senza distinzione.
C’è però un punto spesso omesso nel dibattito pubblico: l’incenerimento illegale dura da almeno vent’anni ed è legato alla mancanza di infrastrutture. In tutta la Cisgiordania esistono solo due discariche funzionanti. Per molti Comuni palestinesi portare i rifiuti fino a lì è costoso e logisticamente complesso. Bruciarli diventa, di fatto, l’unica soluzione disponibile.
Dall’emergenza ambientale alla crisi umanitaria
Un rapporto del revisore dei conti israeliano ha criticato l’Amministrazione civile per non aver mai creato un sistema di smaltimento efficace. Eppure, mentre oggi si parla di “terrorismo ambientale”, per anni non sono stati stanziati fondi adeguati per prevenire il problema. Il ministero della Protezione ambientale aveva chiesto 41 milioni di dollari per contrastare gli incendi, ma quelle risorse non sono entrate nel bilancio statale. Come ha denunciato Yaniv Bleicher di Citizens for Clean Air, “i cittadini continuano a pagare con la propria salute”.
La contraddizione diventa ancora più evidente se si guarda a Gaza. Mentre in Cisgiordania l’inquinamento è trattato come una colpa da reprimere, nella Striscia il sistema ambientale è semplicemente collassato. Acqua potabile, fognature, elettricità: tutto è oltre il limite. In queste ore, bambini muoiono di freddo in un territorio dove mancano energia, riscaldamento e strutture adeguate. Qui non si parla di roghi illegali, ma di una popolazione intrappolata senza servizi essenziali.
Senza infrastrutture, senza investimenti e senza una gestione condivisa delle risorse, l’inquinamento non è una scelta ma una conseguenza inevitabile. E mentre si discute di sicurezza e sanzioni, la crisi ambientale e quella umanitaria continuano a intrecciarsi, colpendo prima di tutto i più vulnerabili.