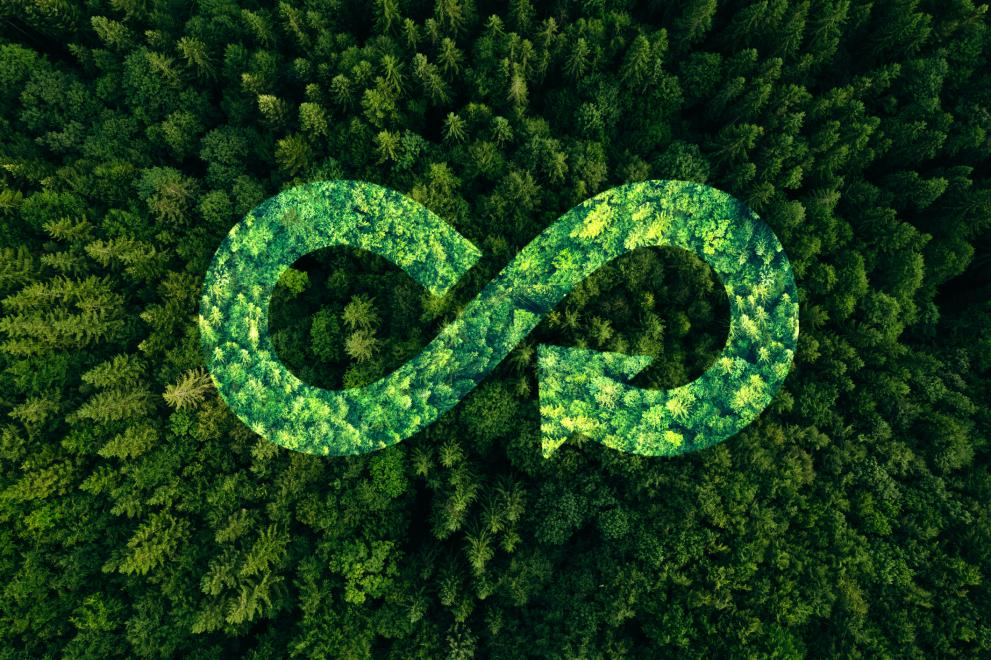Lungo le rive del Tigri c’è un punto in cui l’acqua è una condizione dell’esistenza. Per lo sceicco Nidham Kreidi al-Sabahi, leader religioso dei mandei (una delle più antiche religioni gnostiche del mondo, ridotta in Iraq a 10 mila persone), bere da un fiume che scorre non è una scelta: è un obbligo spirituale. “No water, no life” (No acqua, no vita, ndr), dice al Guardian, ricordando che per la sua comunità l’acqua ha la stessa importanza dell’aria. Il problema è che il Tigri, oggi, scorre con un flusso sempre più ridotto.
Il grande fiume mesopotamico, che nasce in Turchia e attraversa l’Iraq fino a congiungersi con l’Eufrate, è al tempo stesso colonna vertebrale ecologica e archivio vivente della storia umana. Sulle sue sponde sono nate l’agricoltura organizzata, la scrittura, la ruota. Oggi circa 18 milioni di iracheni dipendono direttamente dalle sue acque per bere, irrigare, produrre energia. Eppure il Tigri è malato: inquinato, impoverito, frammentato da dighe e da una gestione che non regge più la pressione combinata di conflitti, cattiva governance e crisi climatica.
Secondo quanto ricostruisce il Guardian, il degrado non è improvviso. Le infrastrutture idriche irachene, un tempo tra le più avanzate della regione, furono colpite durante l’operazione militare statunitense Desert Storm del 1991, che prese di mira anche impianti civili strategici. Da allora, depuratori distrutti e mai pienamente ricostruiti hanno lasciato che scarichi fognari, rifiuti industriali, residui agricoli e sanitari finissero nei fiumi. Oggi solo il 30% delle famiglie urbane è collegato a un sistema di trattamento delle acque reflue; nelle aree rurali si scende all’1,7%. Il risultato è che nel 2018, a Bassora, oltre 118.000 persone sono finite in ospedale dopo aver bevuto acqua contaminata.
Alla perdita di qualità si aggiunge quella di quantità. In trent’anni il flusso del Tigri verso Baghdad si è ridotto di circa un terzo, in gran parte per le grandi dighe costruite a monte, in Turchia, e per le deviazioni operate dall’Iran sui corsi d’acqua condivisi. All’interno dell’Iraq, l’agricoltura assorbe almeno l’85% delle acque superficiali, spesso con sistemi di irrigazione inefficienti. Il risultato è un fiume sempre più basso: nell’estate scorsa, in alcuni tratti, lo si poteva attraversare a piedi.
La crisi climatica amplifica tutto. Le precipitazioni sono diminuite di circa il 30% e il Paese sta vivendo la peggiore siccità da quasi un secolo. Meno acqua significa anche più concentrazione di inquinanti, come osserva Salman Khairalla, fondatore dell’ong Humat Dijlah: la qualità dell’acqua dipende dalla sua quantità.
Nel tentativo di arginare il collasso, Baghdad e Ankara hanno firmato a novembre un meccanismo di cooperazione su irrigazione, controllo dell’inquinamento e governance idrica, finanziato con fondi petroliferi iracheni. Il governo lo ha definito “storico”. Critici ed esperti, però, parlano di un accordo poco trasparente, non vincolante e politicamente opportuno, siglato a ridosso delle elezioni.
Intanto, lungo il Tigri, il tempo stringe. Per i mandei, l’acqua corrente è necessaria per ogni passaggio della vita, dalla nascita alla morte.