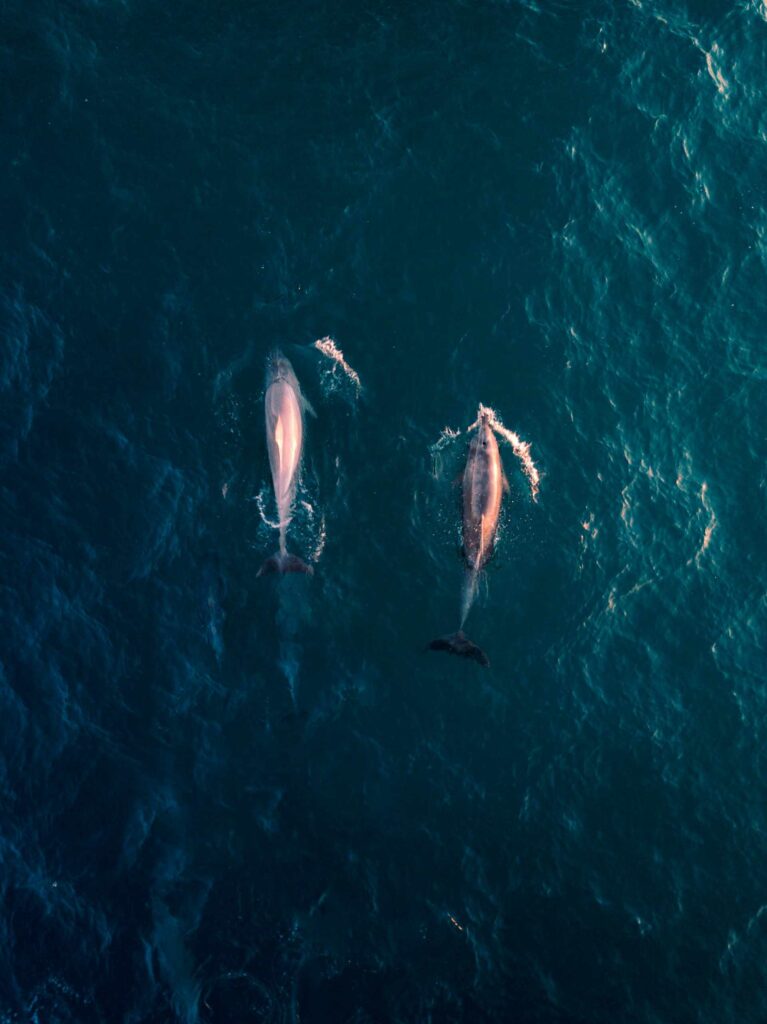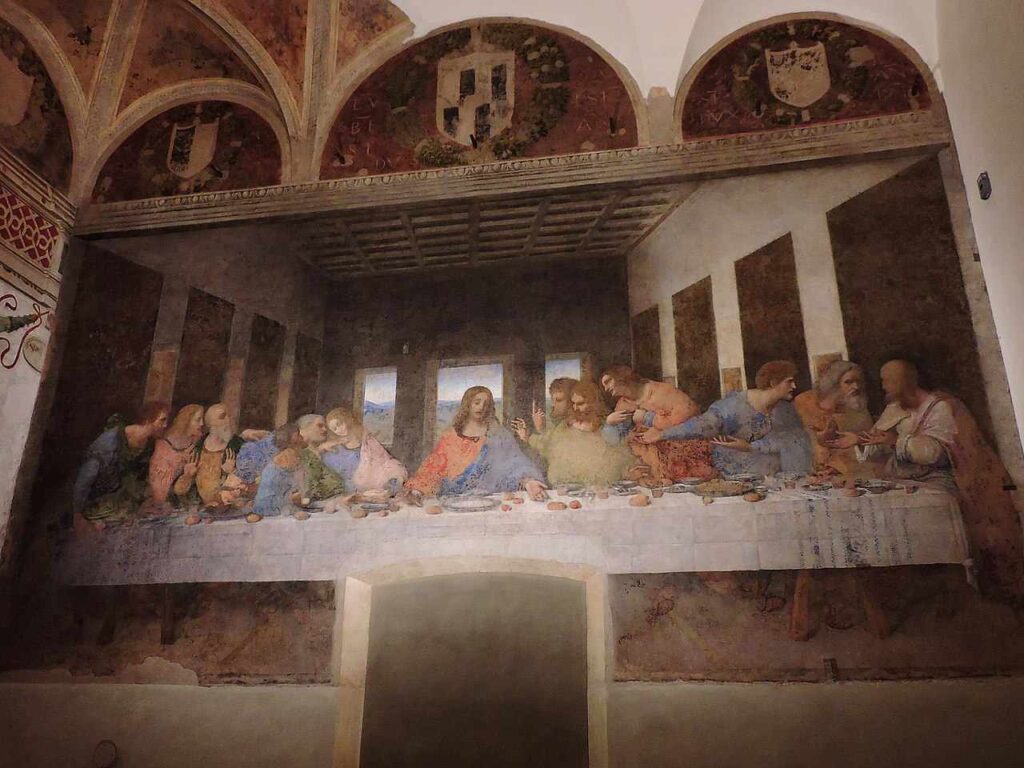I piani statunitensi di rilancio dell’estrazione petrolifera in Venezuela rischiano di avere un impatto sproporzionato sugli equilibri climatici del Pianeta. E non solo per la quantità immediata di barili che tornerebbero sul mercato, ma anche per il peso che questa scelta avrebbe su uno spazio sempre più ristretto: il bilancio globale di carbonio ancora disponibile.
Secondo un’analisi esclusiva condotta da ClimatePartner per il quotidiano inglese The Guardian, l’espansione della produzione venezuelana potrebbe arrivare a consumare entro il 2050 circa il 13% del budget mondiale di emissioni compatibile con l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 °C. Un singolo Paese, con una singola filiera fossile, assorbirebbe così una quota significativa del margine che resta all’intero Pianeta.
Che cos’è il bilancio del carbonio
Il concetto di bilancio del carbonio è centrale nel dibattito climatico, ma spesso resta astratto. In termini semplici, indica la quantità massima di anidride carbonica che può ancora essere emessa a livello globale mantenendo una probabilità realistica di non superare una certa soglia di aumento della temperatura media. Per gli scienziati del clima, 1,5 °C rappresenta il limite oltre il quale aumentano drasticamente i rischi di eventi estremi, perdita di ecosistemi e instabilità sociale.
Le riserve petrolifere accertate del Venezuela sono le più grandi al mondo, almeno sulla carta. Se venissero sfruttate integralmente, basterebbero da sole a esaurire l’intero bilancio di carbonio compatibile con i 1,5 °C. Uno scenario considerato improbabile, anche perché l’industria petrolifera del Paese è oggi segnata da infrastrutture fatiscenti e anni di sanzioni internazionali.
L’intervento degli Stati Uniti
Il contesto è però cambiato rapidamente. Dopo il rapimento del presidente Nicolás Maduro da parte delle forze speciali statunitensi e il suo trasferimento a New York, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sollecitato apertamente le compagnie petrolifere a investire 100 miliardi di dollari per rilanciare la produzione venezuelana. “Estraiamo cifre in termini di petrolio come poche persone hanno visto”, ha dichiarato ai dirigenti del settore.
ClimatePartner ha modellato uno scenario che prevede un aumento della produzione di 0,5 milioni di barili al giorno entro il 2028 e un’ulteriore crescita fino a 1,58 milioni di barili al giorno tra il 2035 e il 2050. Anche così, si resterebbe ben al di sotto dei 3,5 milioni di barili al giorno raggiunti negli anni Novanta, durante l’ultimo grande boom petrolifero del Paese.
Eppure, l’impatto climatico sarebbe enorme: quello stesso scenario “moderato” consumerebbe da solo il 13% del bilancio globale di carbonio residuo, l’equivalente di quasi dieci anni di emissioni complessive dell’Unione europea.
Il greggio più inquinante
A rendere il caso venezuelano particolarmente critico non è solo la quantità di petrolio, ma la sua qualità. Secondo le stime del settore, quello estratto in Venezuela è il greggio a più alta intensità di carbonio al mondo. È un petrolio pesante, denso, con un elevato contenuto di zolfo, che richiede processi di estrazione e raffinazione molto più energivori rispetto ai greggi convenzionali.
Uno studio di S&P Global Platts Analytics ha rilevato che i giacimenti della Cintura dell’Orinoco presentano di gran lunga la più alta intensità di carbonio tra tutte le principali regioni petrolifere. Il confronto è netto: circa 1.460 kg di CO₂ equivalente per barile di petrolio equivalente, contro gli 1,6 kg del giacimento norvegese Johan Sverdrup. Il rapporto parla di un’intensità “estrema”, difficilmente sostenibile in un mondo vincolato da budget di carbonio sempre più ridotti.