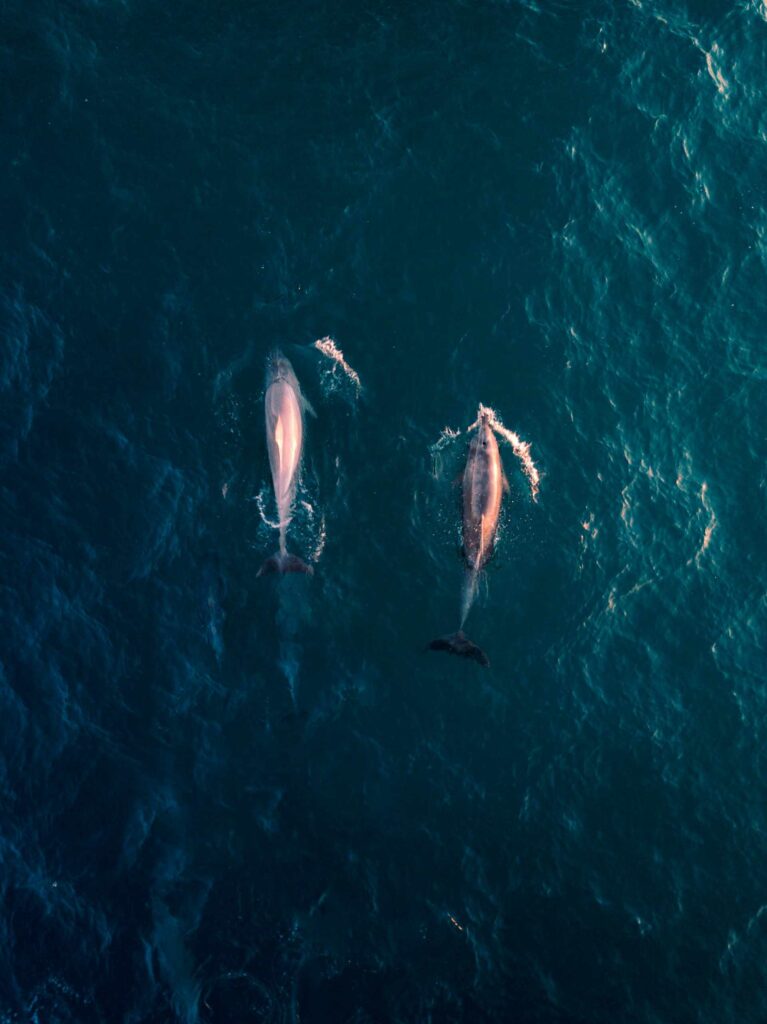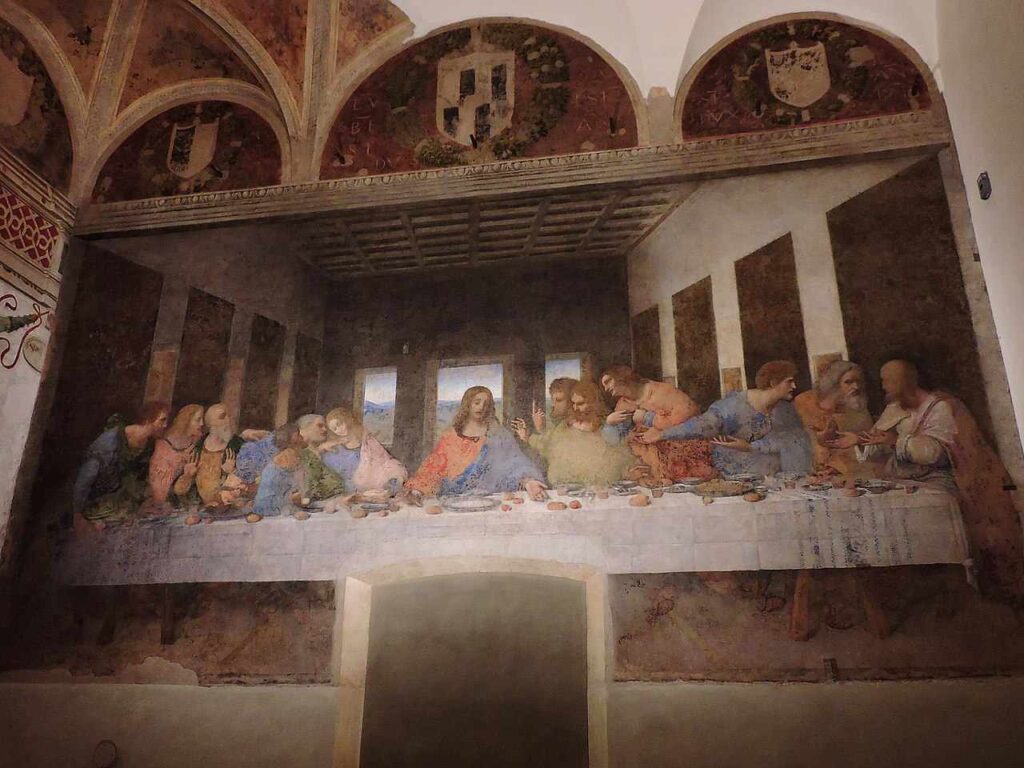Per un orango, scegliere cosa mangiare non è affatto una questione di istinto. È piuttosto una faccenda di osservazione e lunga pazienza, di “cultura” potremmo dire. Ad affermarlo è uno studio del Max Planck Institute for Animal Behavior, pubblicato su Nature Human Behaviour, che getta nuova luce su uno degli aspetti meno intuitivi della vita delle grandi scimmie: la loro dieta.
Gli oranghi selvatici di Sumatra “portano a tavola” una varietà impressionante di alimenti – si nutrono di circa 250 specie diverse tra piante e animali – e, secondo i ricercatori, sarebbe impossibile imparare tutto questo affidandosi solo al meccanismo di prova ed errore. Troppo rischioso, troppo lento. Alcuni cibi sono stagionali, altri difficili da processare, altri ancora potenzialmente tossici se mangiati nel modo sbagliato. La soluzione? Imparare dagli altri.
Lo studio mostra che la conoscenza alimentare degli oranghi è un vero e proprio repertorio culturale che si costruisce nel tempo grazie all’apprendimento sociale. I ricercatori hanno usato un modello di simulazione basato su 12 anni di osservazioni sul campo per capire se un giovane orango potesse, da solo, acquisire tutte le competenze necessarie prima di diventare indipendente, attorno ai 15 anni di età. La risposta? È no.
Il modello includeva tre comportamenti sociali chiave. Il primo è il peering, cioè l’osservazione ravvicinata di un altro orango mentre mangia. Il secondo è la proximity, la semplice vicinanza a individui che si nutrono, che stimola l’esplorazione di cibi simili. Il terzo è la guida verso specifici siti di alimentazione. Solo quando tutti e tre questi canali erano disponibili, gli oranghi “virtuali” riuscivano a sviluppare una dieta completa, simile a quella degli adulti selvatici. Togliendo anche solo l’osservazione ravvicinata, il repertorio alimentare si fermava all’85%. Eliminando anche la prossimità, la dieta diventava drasticamente più povera. Senza una comunità da osservare, l’orango non diventa davvero orango.
Questa scoperta ha implicazioni che vanno ben oltre la biologia della conservazione. Secondo gli autori, i risultati suggeriscono che le radici dell’accumulo culturale umano – la capacità di trasmettere conoscenze complesse di generazione in generazione – potrebbero risalire ad almeno 13 milioni di anni fa, fino all’ultimo antenato comune tra esseri umani e grandi scimmie. In altre parole, la cultura non nasce con l’Homo sapiens: affonda le sue radici molto più indietro nel tempo.
C’è poi un risvolto pratico, e urgente. I programmi di reintroduzione in natura degli oranghi orfani o cresciuti in cattività devono tenere conto di questo “menu culturale”. Non basta rimettere un animale nella foresta: se non conosce l’intera gamma di cibi commestibili e le modalità corrette per consumarli, il rischio è la fame o l’avvelenamento. La sopravvivenza passa anche – e soprattutto – dalla trasmissione del sapere.
Una curiosità che rafforza questo quadro: gli oranghi sono noti per avere uno dei periodi di dipendenza materna più lunghi del regno animale, fino a otto-nove anni. Un tempo che oggi appare sotto una nuova luce: non solo crescita fisica, ma una lunga “scuola di vita” fatta di osservazione, imitazione e memoria. In silenzio, tra le chiome della foresta, si costruisce una cultura che vale quanto qualsiasi manuale di sopravvivenza.