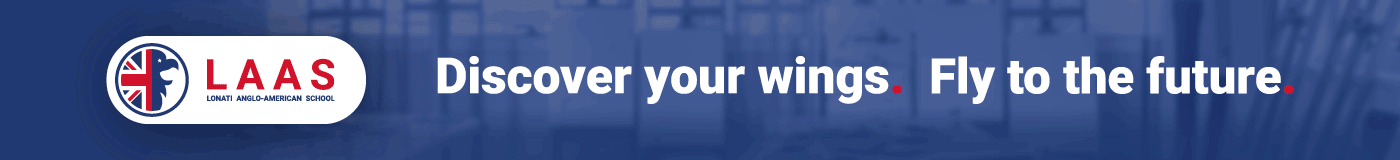08.05.2024
Un segmento di storia apparentemente lontanissimo e dimenticato. Da Eduardo Scarpetta al principe della risata Totò, si compie il tragitto di un teatro filmato che non ha eguali, quello della figura del piccolo borghese che continua la sua evoluzione sovrastando ogni realtà.
Siamo quel che siamo stati. Il cinema (come il teatro) ripercorre il passato per approdare ad un approdo plausibile nel presente. Il regista Mario Mattòli nell’affidare al “principe della risata”, l’immaginifico Totò, i panni laceri di Felice Sciosciammocca, figura di piccolo borghese, un po’ furbo e costretto agli espedienti per lottare contro la povertà, aveva sposato lo spirito esuberante di Eduardo Scarpetta, il grande patriarca della scena partenopea, capace di strappare, tra una sfogliatella e una scappatella, testo dopo testo, la maschera di Pulcinella di Petito. «Il ridicolo è il rovescio del sublime», Benedetto Croce. Così Miseria e nobiltà scritto nel 1887 e diventato film nel 1954, pur ambientata nella Napoli lontana della Belle Èpoque, distillando un inno al passato più scalcinato, astuto, provvisorio, in cui l’unico copione è dettato dalla sempiterna fame, dal senso di precarietà e dal tarlo della provvisorietà nei rapporti sociali, con il grimaldello della guittaggine (cioè, del tentativo vano di aggirarla), travalicava il quadro storico a faceva da contrappunto ad un’Italia, quella del Boom nascente, ancorata ad un passato incerto da risolvere, magari con l’arma della menzogna per riscattarsi dal disagio. Nel basso napoletano di fine Ottocento, affondato nel buio di problemi irrisolti, la realtà sconfina nella finzione scenica, si fa arte e fotografa un’epoca. All’indomani della chiusura del glorioso San Carlino, quintessenza di valori linguistici, letterari ed espressivi della tradizione, abbinando tradizione ed un’improbabile modernità, s’impone un nuovo modello di vita e di cultura di derivazione francese, ed è proprio Eduardo Scarpetta, organico alla borghesia rampante (che si riconosce nei suoi personaggi bonari) a fungere da tramite, reinventando il vaudeville con l’immissione di umori, colori e sapori intinti nel ragù napoletano. In Miseria e nobiltà, mix di dramma e farsa, comica parodia, sguardo borghese privo di “pietas”, i fili si riannodano tutti, e innescano un meccanismo perfetto, paradigmatico di un’intramontabile, gloriosa sapienza teatrale. E icona del cinema popolare italiano.
Le disgraziate vicissitudini di Don Felice Sciosciammocca (un Totò scintillante), scrivano disoccupato stretto nella sua patetica giacchettina e favorevole al “trionfo” dell’ignoranza, e di Pasquale (Enzo Turco), salassatore senza clienti, che si scalda le mani su un braciere privo di carboni ardenti, sono il segno evidente di un mondo in trasformazione. È naturale, allora, che i due poveracci, con famiglia annessa, accettino di travestirsi da nobili, fingendosi i parenti di un marchesino innamorato, allo scopo di favorirne il matrimonio contrastato con una ballerina del Teatro San Carlo (la seducente Sophia Loren). L’improbabile salto sociale dei due nasconde a malapena lo stato di disagio, tanto che ben presto le loro mosse si aggrovigliano attorno al tema atavico della fame, mascherandosi solo fittiziamente nei panni dei nobili d’occasione, colti nei loro risibili tic e nella fasulla albagia. E la scena irripetibile del pranzo succulento offerto in un clima metafisico, davanti agli spaghetti fumiganti (per rimpinzare anche le tasche) o l’ingresso trionfale degli impostori nella casa sfarzosamente pacchiana del cuoco arricchito (e ignorante), intessuta di equivoci, scambi d’identità, storpiature lessicali e velate critiche ad una vacua e grottesca nobiltà, in un serrato intreccio di rimandi e battute esilaranti, s’innerva dello stravolgimento della “lengua”(ultimo baluardo) capace di produrre metafore, però. Un “vulcano” eruttante vezzi, lazzi inesauribili, incardinati in una capacità ferina d’improvvisazione, che s’impossessa dei toni crepuscolari di una rassegnata malinconia, allontanandosi dai logori stereotipi oleografici, per essere percorsa da sussulti di modernismo. «Noi nel caffellatte, non mettiamo niente, né latte né caffè». Il disagio di chi non ha.