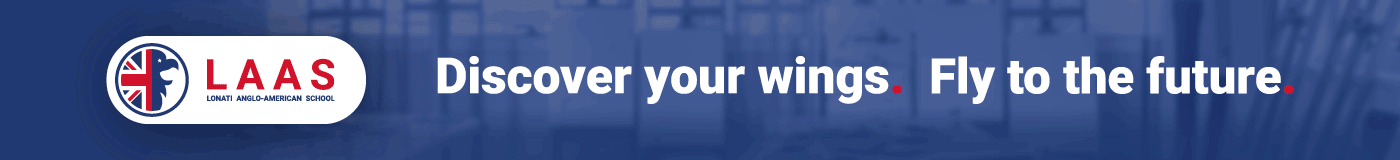02.02.2024
«Il teatro serve alla vita, ne è una ‘dimostrazione’», dice l’eterno teatrante Glauco Mauri. Oggi sulla soglia dei 94 anni, un mostro sacro del teatro, ancora dispensa lezioni di vita con leggerezza e sicura baldanza. Perché sulla scena si gioca la partita della vita. In ricordo di Roberto Sturno, interpreta “Minetti, ritratto di un artista da vecchio”.
Alzato il sipario, nello spazio dilatato del Piccolo Teatro Strehler, le parole di Glauco Mauri iniziano a trasformare la scena in una sorta di arena dove confrontarsi, conoscere, perché “ti rende ricca la vita, te la fa capire”. Ci sono bagliori di curiosità prensile in quello sguardo mite ma battagliero, lontano da ogni compromesso, ora che le primavere si affastellano, perché veste i panni di “Re Lear” ancora una volta (più di 500) dopo i ventiquattro personaggi shakespeariani interpretati.
Ma stavolta il crogiolo di umanità, quella frattura tra padri indegni e figli inetti, si raggruma, trasversalmente, nel mondo visionario di “Minetti, ritratto di un artista da vecchio” (1976) di Thomas Bernhard, che da trent’anni non recita più ‘Lear’, mentre il direttore del teatro di Flensburg vuole farglielo reinterpretare.
Dentro la hall d’un anonimo albergo di Ostenda, in una desolata ultima notte dell’anno, l’attesa si fa sospensione. Appesantito da un cappotto ed ancorato ad un bastone, con la sua fida valigia che serba una maschera speciale, ecco Glauco su quella poltrona, a permeare gli umori ossessivi di Minetti, vecchio e glorioso attore, mentre per un effetto di nemesi (personaggio/attore) la carriera si srotola come un nastro. Non quello beckettiano di Krapp contro fallimento o vecchiaia ingrata, al contrario il segno di un mostro sacro ancora capace di dominare la scena con voce ferma e memoria prodigiosa. Con in più l’immarcescibile dote legata al senso che abita ogni suo personaggio, nella poliedricità dell’essere umano. Un senso profondo, leggero, ad incarnare gesti, ragionamenti, sul piano inclinato che dal drammatico trasmuta in commedia, in quel meraviglioso gioco di specchi che aveva incantato Mauri, agli esordi nel 1946, in un teatrino. Ora, una folla minuta dei comprimari, a sipario aperto, attraversa lo spazio algido tra improvvisati conigli in frac, un nano, uno storpio, ospiti improbabili di una festa surreale. Minetti-Mauri scruta, si stupisce, fors’anche per la scelta registica (ardita) di Andrea Baracco, ascrivibile solo all’Interno Bernhard (il titolo della serata), dove la “t” va sostituita dalla effe.
Allora, l’inferno dell’autore austriaco e le cascate di parole (Workaskaden) trascinano dolore e rabbia, acredine e risentimento, sul filo di una sintassi spezzettata, tutta articolata su un flusso incontrollabile di umori stizzosamente contraddittori, ad incanalare l’odio del grande attore tedesco, nell’attesa di Lear, dopo essere stato cacciato via da Lubecca, perché si sa “i direttori di teatro sono sempre inaffidabili”. Sul piano della ruvidezza, la riflessione nera si colora di grottesco, l’intonazione pseudo filosofica cede il passo all’umorismo, trasformando la critica al vetriolo del sistema sociale in strali contro ipocrisia, stupidità, incultura. La resistenza morale ed individuale è musicale. Nel vortice di rimpianti, ossessioni e appunti contro convenzioni e storture di un teatro finto, per contrappasso c’è il bisogno bernhardiano di un’arte da rinnovare e di una recitazione autentica. «Il mondo pretende di essere divertito e invece va turbato. Chi si è dato alla mortale arte drammatica si è ferito a morte». L’Uomo per esistere deve conoscere sé stesso. Lear, imprigionato dalla vecchiaia e dalla malvagità delle sue figlie ingrate, è lì. Mentre la neve scende soffice. In attesa di un appuntamento che non ci sarà. «La vita è una farsa che i furbi chiamano esistenza». Minetti-Mauri sorride amaramente.