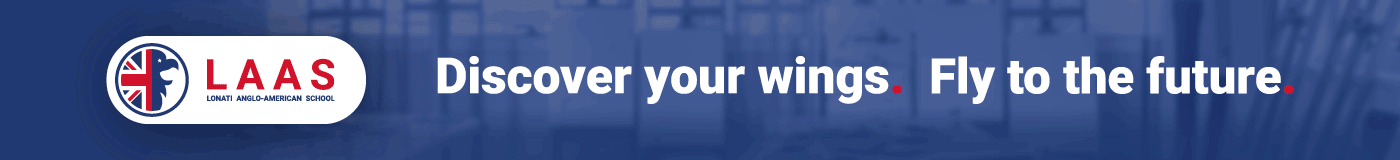06.03.2024
La visionaria messinscena di Elio De Capitani trasforma l’avventura in un apologo sul senso di una sfrenata corsa verso la distruzione dell’ambiente che ci circonda.
Sul filo rosso immaginifico di Orson Welles e il suo Moby Dick alla prova (1955), che lega la follia di Re Lear a quella del capitano Achab, accecato da un’ossessione tracimante, corre il senso del delirio che precipita nel vortice dell’ignoto tutto l’equipaggio della sua Pequod, la baleniera. Per traslato è la stessa sindrome d’onnipotenza dell’uomo contemporaneo, infarcito di false certezze dietro lo scudo (im)permeabile di hybris, quella sicumera che sfida la natura credendo illusoriamente di addomesticarla. Il capodoglio bianco Moby Dick, personificazione del male, va sconfitto, in quel furente vitalismo, al di là dell’etica, verso il passo fatale. L’equivalente (nella nostra società) dello status d’apparenza e disagio esistenziale, con i tanti che, per inseguire i loro Moby Dick, calpestano democrazia, diritti e regole della convivenza, smarrendo prospettiva e dignità, nello sfregiare la natura in un impeto d’autodistruzione. Così baleniera e ciurma di fedelissimi protesi verso la sfida finale si fanno metafora di un’umanità smarrita, soggiogata dall’ambizione, corrosa dalla presunzione, accecata dall’odio. Sul ciglio del baratro. Dall’economia ai temi ambientali, dai rapporti interpersonali ai dilemmi sociali e alle crescenti disuguaglianze.
Il teatro che interroga, irrompe, inseminando dubbi e riflessioni d’un viaggio onirico dentro uno psicodramma shakespeariano, snodantesi attraverso le prove di una compagnia, nel passaggio Re Lear-Moby Dick (due re assetati di vendetta, di assoluto) declinato da Welles come giuramento di fedeltà dell’equipaggio al suo capitano, che solo con la morte della balena potrà liberarlo dalla prigione d’odio in cui è rinchiuso, ma non sciogliere i nodi immersi in un cono d’acqua senza fondo. Un gorgo mortale che al pari della Pequod inghiotte l’umanità intera, artefice della propria rovina per ambiguità congenita, insipienza o mire predatorie altrui. E allora, il palco dell’Elfo-Puccini, ventre-tolda della baleniera, diventa (in)cubo attraversato da luci livide, ben dentro un mantice che si rigonfia e sfiata, con quel suo telo di seta striata che avvolge gesti, volti, prezioso megafono della vita interiore dei protagonisti. Spazio disadorno fasciato da canti di marineria, tra alte scale di ferro da cui scrutare il mare, e tavoli con i lacerti cetacei della provvidenza (teologia quacchera baleniera, poi industria), per ospitarne poi l’incombente immagine come minaccia della natura che geme per l’olocausto marino e per i soprusi dell’uomo contro animali ed umani (schiavitù e stermini compresi).
Sul filo dell’evocazione che annulla (troppo?) il mare, capodogli e navi, eppure li restituisce, assecondando il ritmo narrativo del blank verse shakespeariano, nel mosaico multigenerazionale dell’Elfo, rabbiosamente capace di proiettare l’impronta fantasmatica della fissazione assoluta di Achab. La geografia del teatro è fasulla, offre scorci e non posizioni, lavora per immedesimazione e non per precisione, ma rimane il tramite per vivere quell’angoscia che rimbalza dall’allegoria all’oggettività e fa riaffiorare il borderline, quella trama sottile di trestizia, lo stato perpetuo di dolore, che con sottile maestria Melville secerne dal libro, Welles distilla, ed Elio De Capitani (Capocomico-Lear-Padre Mapple-Achab) incarna con visionaria spietatezza nel suo lavoro di ricerca radicale per cogliere la rappresentazione segreta di Peter Brook, pur con “percorso brechtiano”. Mentre l’onda sciaborda, scroscia, schianta. Non c’è, ma è lì, nelle nostre coscienze, e ci invita ad evitare il fondo.