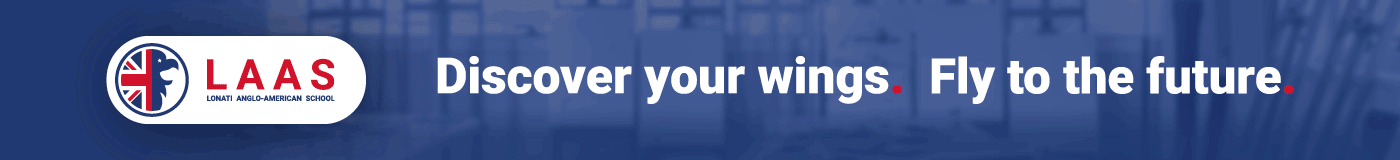23.01.2024

Fuoriclasse di signorilità, di correttezza, ma anche di etica applicata al pallone. Non era un personaggio che amava la retorica, ma che è entrato di diritto nella storia del nostro Paese, dando un calcio a convenzioni e luoghi comuni.
A volte le storie s’ammantano di fascino e trasmigrano nella leggenda. Senza le tanto avversate iperboli, assecondando un carattere schivo e refrattario al parossismo, le vicende di un uomo di calcio, diventato personaggio suo malgrado, si trasformano in compendio socio-antropologico. Irrompe, folgorante, il ricordo di Gigi Riva, sintesi perfetta brianteo-bassaiola del popolano lombardo, come avrebbe detto Giôannbreafucarlo (Gianni Brera), che dalle nebbie padane del piccolo borgo di Leggiuno (nel varesotto) un giorno, all’improvviso, sognò di diventare un calciatore professionista. La perdita del padre, l’ostinazione della madre a tirare avanti, e quell’esistenza da raccogliere nelle mani tirando dei calci ad un pallone, erano stati il magma incandescente di una passione immersa nei prolungati silenzi che gli avevano sussurrato: «Arrangiati. E io mi sono dovuto arrangiare… Il calcio mi ha aiutato, mi ha dato tanto per non dire tutto».
Con la voglia di schivare le umili origini e trasformare un “calciatore operaio” che faceva gli allenamenti alla sera dopo il turno al tornio, in una promessa in Serie C e quelle 37 mila lire del primo stipendio, prima del gran salto. 1963: con la sua piccola valigia di diciottenne sbarcò in quella Sardegna ritenuta allora terra di «banditi e pastori», e vissuta inizialmente come una sorta di deportazione, che diventò la sua “isola”. Il costo del cartellino di 37 milioni da parte del Cagliari, si rivelò un investimento d’oro. Stava nascendo il più grande attaccante italiano del dopoguerra, capace d’imprese mirabolanti, gol in rovesciata, bordate da fuori area con quel “mancino divino” che piegava le mani a portieri inermi, fino all’apoteosi sportiva della vittoria nel campionato 1970, con la maglia bianca guarnita di laccetti al collo bordato di rossoblù, e uno Scudetto cucito all’altezza del cuore. Una vera impresa che aveva ribaltato luoghi comuni, contrapponendo il manipolo di giocatori guidati da Manlio Scopigno, l’allenatore-filosofo, nella favola che aveva sfidato il sistema calcio, quello ricco, quello dei potenti. Con Giggirriva che s’era trasformato in condottiero d’un intero popolo in cerca di riscatto sociale sui banchi della storia.
Schivo, riservato, sempre in seconda fila se c’era da festeggiare, in prima se invece bisognava fronteggiare le situazioni, è come se avesse introiettato il “Procurade ‘e moderare, barones, sa tirannia”, abbassare la cresta, o baroni, come cantavano gli insorti dei moti antifeudali alla fine de ‘700. Avvolto nella nuvolaglia delle sue cento sigarette, sorrideva al sentire “Rombo di tuono” coniato per lui dal buon Brera, perché aveva sempre dismesso i panni della divinità (al contrario della boria odierna) per indossare quelli schietti e senza fronzoli di chi voleva circondarsi d’amici, con eloquenti silenzi e quel fare fiero tipicamente isolano. Una signorilità nei modi che contrastava quella di emergere, di segnare sempre e comunque.
L’ultimo flash: Italia-Germania, Mondiali in Messico, 17 giugno, stadio Atzeca. Quel fendente che sembra una rasoiata, e il pallone che s’insacca ancora accende la fantasia. L’uomo che aveva detto di no alla Juventus, gioiva per l’adorata maglia azzurra. E l’Italia, in festa, con lui. E ora che è uscito dal campo verde, rimane il mare delle Saline del Poetto, le corse notturne a Villasimius. E poi, la Barbagia, l’Ogliastra, una geografia sentimentale da “vecchio e il mare”, una saggezza appresa dai racconti di pescatori, i luoghi dell’anima intrisi del calore umano della sua gente. Sparita l’epica, rimane lui: Gigi riva, lo schivo.