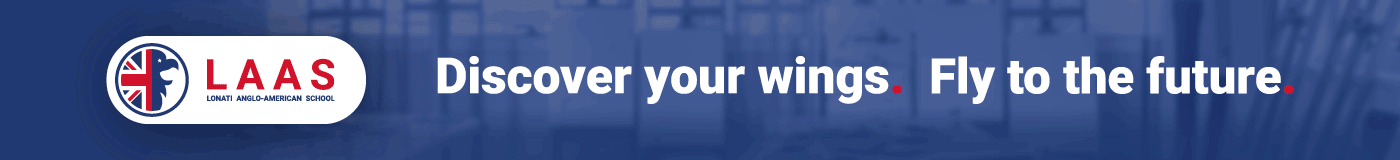10.11.2023
L’Italia detiene il primato dell’inglese “farlocco”, che per molti rappresenta solo un dinamismo linguistico, frutto della nostra “lingua vitale”. Terminologie che diventano contenitori vuoti. Una tendenza amata dai più giovani, autori di parole che sanno di ibrido come ‘boomerata’, ‘cringiata’ o ‘linkare’.
Si potrebbe partire da Piazza del Duomo e fare compagnia immaginaria a Totò e Peppino, spaesati nella metropoli, per comprendere che la richiesta al ghisa milanese “Noio voulevam savoir…l’indiriss…ja”, rimane inalterata come simbolo emblematico della nostra incapacità ad utilizzare una qualsiasi lingua.
E con essa la tendenza prossima all’innocente protervia di improvvisarsi poliglotta, con strafalcioni, neologismi e pastiche lessicali, perché in fondo siamo tutti eredi di quello spirito ludico mutuato dalla commedia dell’arte. Un po’ Dario Fo ed il suo grammelot, un po’ Adriano Celentano e quel mix rock-rap di Prisencolinensinainciusol (1972), scimmiottante suoni e cadenza inglese.
Non sappiamo le cose, e allora, prima di studiarle, le affidiamo alla proverbiale improvvisazione, corredata da gesti e figurazioni, forse retaggio di una mancata storia identitaria nazionale, spesso assoggettata a più padroni (vedasi dominazioni), e di una condiscendenza esterofila che, attraverso l’autodegrinazione, ci ha portati ad esaltare le vicende al di là delle Alpi. L’infatuazione per l’inglese, a cavallo della Seconda guerra mondiale con l’arrivo delle truppe alleate liberatrici, mentre lo stesso Renato Carosone cantava “Tu vuo’ fa l’americano”, ha conferito alla lingua un effetto di richiamo perché, come asserisce la linguista terminologa Licia Corbolante:
«Se si usa l’inglese, si trasmette modernità, feschezza,
progresso tecnologico e, in un certo senso, status».
Ma visto che, manzonianamente, siamo propensi a risciacquare i panni in Arno, siamo andati oltre diventando gli inventori del fake English. Nel segno di creatività linguistica, giocosità e aperture globali, nell’incorporare inglesismi in modi non convenzionali. Col sorriso sardonico modello-perfida Albione, lo ha sottolineato di recente l’autorevole Financial Times, cogliendo con le mani “in the marmelade” chi tentava di rubare la marmellata, cioè noi. Così il nostro italiano zavorrato da greco e latino, volendo ambire alla contemporaneità, ha fagocitato prestiti e calchi dall’idioma british, creando ad hoc un “inglese farlocco”, in puro stile gibberish, alias parola inintellegibile. Provate ad esprimervi con alcuni di questi termini nella City londinese, vi prenderanno per marziani! L’ibridizzazione tra parole comunemente usate oltremanica e tradotte artificiosamente in italiano con tutt’altro significato, ha generato una sorta di sottocategoria di pseudoanglicismi palesemente finti.
Lo smart working, il lavoro da casa, si chiama remote work; golf, in GB solo sport, è il nostro maglione (sweater in inglese); il lifting in italiano procedura estetica, è facelift; pullman e autostop da noi, al posto di intercity bus e hitchhiking; Black Friday o days perdono le connotazioni negative e invogliano gli acquisti. Ci si può inoltrare nel ginepraio (morfosintattico, per carità!) di parole che assomigliano all’originale ma che significano altro come mister, pile, front runner, flipper, o non esistono proprio, quali stender, job on call, stepchild adoption, per esplorare il mondo del finto dichiarato, dove nomi di prodotti, slogan, servizi sono pensati da italiani per italiani, nel continuo assemblaggio di parole “english assai” poco idiomatiche, a volte errate o assenti, però facilmente comprensibili da chi ha solo conoscenze scolastiche dell’inglese. Ogni spiegazione viene ritenuta superflua: basta tradurre letteralmente come next opening, “prossima apertura”, e tanto basta. Italiani, brava gente, un po’ meno con le lingue!