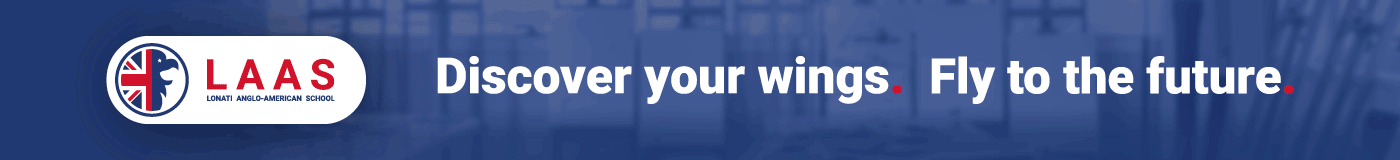09.10.2023
Dalle Ambasciate, gli aeroporti e i flirt melò con la bellissima di turno, all’uomo che preferisce le scazzottate e le ossa rotte agli altri. Da impenetrabile a vulnerabile, la metamorfosi letteraria di una figura maschile che domina sul tempo.
Seducente col suo profilo disegnato dal vento l’Aston Martin DBS ci accoglie. Ma sì, è la macchina cult di James Bond che morde l’asfalto per un giro tra i Sassi di Matera. Al fianco, di Daniel Craig (ora), Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, la fantasia galoppa serpeggiante tra ambasciate, aeroporti, spie, attacchi terroristici, e flirt melò con la bellissima di turno. Sembra un film. Anzi lo è. Al 25° episodio, sei dentro la saga più famosa di tutti i tempi: il mondo di 007. Ad inseguire mirabolanti avventure ritmate da: «Il mio nome? Bond, James Bond».
Un ritornello iconico fin dal primo film del 1961 Licenza di uccidere, quando Ian Fleming, già autore di sei romanzi, aveva proposto senza esito la regia ad Alfred Hitchock, impegnato però con Psycho. E tra luoghi esotici, panorami mozzafiato, alberghi di lusso, ad animare vicende prevedibili nella loro imprevedibilità, tutte segnate dall’eccesso e da uno humour molto british (anzi scottisch) arrivò (invece di Cary Grant), il mitico agente speciale Sean Connery al servizio di Sua Maestà. E quello che Alberto Arbasino aveva criticato in Fleming, smarritosi in libri (“impubblicabili”) pieni di cose luccicanti, tra le Antille e le Bermude, rigurgitanti di misteriosi nemici che attentano alla pace del mondo per trarne beneficio, affollate da ragazze-cerbiatto dalle forme scultoree compiacenti e poi avversarie, in un profluvio di sali da bagno, essenze, liquori, lingerie, camere da letto, e alberghi scintillanti con servitù schiavizzata, mentre spie internazionali occhieggiano dagli armadi, incuranti di trappole mortali, rimanda per contrappasso alle intenzioni dell’autore.
Lui, capitano di corvetta co-progettista di un’unità di intelligence (30 Assault) per carpire i documenti dei nemici, era convinto, invece, di aver regalato un sogno ai suoi lettori ancora afflitti dalle restrizioni economiche postbelliche, donando al suo protagonista, anonimo funzionario governativo (dell’MI6), un ricco corredo “teatrale” per dargli risalto (la pistola particolare, i gadget, le sigarette, i cocktail infiniti).
Allora, ecco spuntare il mondo interiore di Bond, che Raymond Chandler (suo, il Philip Marlowe) disdegna preferendo le scazzottate e le ossa rotte agli altri, o quando “prende fra le braccia una ragazza bellissima e pretende di insegnarle cose che lei conosce meglio di lui”. E da Godfinger (1964) che fissò caratteri e modello del Bond successivo, ancor prima che gli effetti speciali invadessero il genere avventura e spy-thriller in un crogiuolo parodistico, l’indole snob-perfezionistica in tutto ciò che fa e lo circonda, dalla ricerca di un gentleman’s club alla sua altezza, alla monomania alcolica (Martini “agitato non mescolato”), e l’aura dell’eroe borghese che difende l’Occidente dai suoi nemici, paladino di virtù liberali e dello stile di vita mondano e godereccio, cominciano a slabbrarsi al passo con una realtà che cambia.
Fascino malandrino e blasé, misogenia e sessismo nei confronti di un mondo femminile caricato sul timing della seduzione (quanto tempo occorre perché una bond-girl ceda?), il mito d’uomo fiondato sull’azione (per la quale vive), pura potenza, lupo che difende le pecore dagli altri lupi, indossando i panni di un omerico Achille contemporaneo, muore due volte, alla fine di No Time to Die (2021): colpito da una pioggia di missili, ma prima ancora dal sentimento di una famiglia mai avuta, per assumere il ruolo di padre. 007 diventa post-moderno.